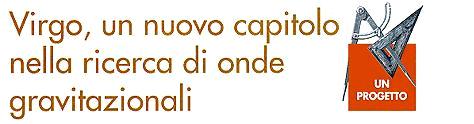|
Le sorgenti delle onde gravitazionali sono molteplici e coinvolgono grandi fenomeni cosmici, come le fasi terminali dell'esistenza di una stella molto massiccia che collassa su se stessa e esplode in supernova prima di spegnersi definitivamente; la formazione di un buco nero; la rotazione veloce di due densissime stelle di neutroni che spiraleggiano l'una attorno all'altra, fino al loro abbraccio (la coalescenza, come dicono gli astronomi) in un unico oggetto. Insomma, fenomeni in cui grandi masse subiscono grandi accelerazioni. La differenza fra la forza gravitazionale di carattere statico, la stessa che ci vincola alla Terra, e quella di carattere dinamico che provoca le onde gravitazionali, si può comprendere meglio facendo un paragone con l'elettromagnetismo. Anche una carica elettrica a riposo, immobile nello spazio, genera un campo elettrico statico in grado di esercitare forze. Tuttavia, se la carica elettrica viene accelerata, essa emette radiazioni elettromagnetiche che si propagano a distanza, alla velocità della luce, e la cui frequenza varia in funzione della dinamica della carica accelerata: onde radio, raggi infrarosssi, luce visibile, ultravioletta, raggi X e gamma (l'elencazione è in ordine crescente di frequenza). Purtroppo, mentre le onde elettromagnetiche hanno un forte impatto con la materia, nel senso che attraversandola cedono una parte della loro energia, e sono facilmente rivelabili da sensori di vario tipo e dal nostro stesso occhio limitatamente alle frequenze visibili (i sette colori dell'arcobaleno), le onde gravitazionali sono molto deboli e hanno una modestissima interazione con la materia. Al passaggio di un'onda elettromagnetica, per esempio un'onda radio, gli elettroni liberi di un metallo vengono indotti a oscillare con la stessa frequenza dell'onda incidente: grazie a questo fenomeno è possibile captare un'onda radio attraverso un'antenna e poi amplificarla con un apparecchio radio. Allo stesso modo, gli atomi di un corpo sono posti in oscillazione dal passaggio di un'onda gravitazionale; ma i loro movimenti oscillatori sono talmente piccoli che le tecnologie finora sviluppate dall'uomo non sono valse a evidenziarli. Così, l'esistenza delle onde gravitazionali, contrariamente a diversi altri fenomeni fisici previsti dalla relatività einsteniana, non ha ancora trovato una verifica sperimentale diretta, malgrado da decenni si siano moltiplicati, in tutto il mondo, esperimenti con diverse tecniche.I primi tentativi di captare onde gravitazionali sono stati sviluppati a partire dalla seconda metà degli anni '60, grazie al lavoro pionieristico di Joseph Weber e successivamente del gruppo di Edoardo Amaldi in Italia. La tecnica usata è stata quella delle barre risonanti, tipicamente formate da cilindri di alluminio della lunghezza di 3 metri e del peso di 3 tonnellate, sospesi orizzontalmente per mezzo di cavi metallici. All'arrivo di un'onda gravitazionale il cilindro dovrebbe oscillare a una frequenza di 900 Hertz. Ovviamente questa vibrazione, amplificata da apparati elettronici, deve essere depurata da tutta una serie di disturbi, introdotti da fenomeni sia naturali come i movimenti geologici, sia artificiali come vibrazioni di apparati meccanici, che provocano un fastidioso rumore di fondo. L'introduzione delle tecniche criogeniche, cioè il raffreddamento del cilindro per ridurre i rumori dell'agitazione termica degli stessi materiali di cui è fatta l'antenna, e i più sofisticati sistemi di sospensione, hanno sì migliorato la sensibilità di questi apparati, ma non fino al punto di fare emergere con assoluta evidenza la vibrazione indotta dalle onde gravitazionali.Un salto di qualità nella sensibilità necessaria per captare le onde gravitazionali sta per essere compiuto in diversi Paesi (Stati Uniti, Giappone e Germania, oltre all'Italia) grazie allo sviluppo di una nuova generazione di interferometri laser che traducono in una piccolissima variazione di luminosità le variazioni di distanza fra due punti prodotti dal passaggio di un'onda gravitazionale. Visitando gli impianti di Virgo, a Càscina, ci possiamo rendere conto di come funziona, in pratica, questo particolare tipo di antenne gravitazionali. Nell'edificio centrale di Virgo un laser a infrarossi genera un fascio altamente stabile che viene diviso in due da uno specchio semitrasparente e inviato verso due piste ortogonali fra loro di 3 km ciascuna. Ciascuna pista è formata da un tubo a alto vuoto, dove la pressione è ridotta a mille miliardesimi rispetto a quella ordinaria, in modo che il raggio non venga disturbato dalla presenza di particelle. In ciascun tubo il raggio rimbalza fra due specchi contrapposti, fino a percorrere 120 km: in questo modo, aumentando il cammino ottico, si amplifica la deformazione prodotta dalla sperata interazione di un'onda gravitazionale sui due bracci del sistema. Quindi i due raggi vengono fatti rientrare nell'edificio centrale, sfasati in modo tale da produrre, per il fenomeno dell'interferenza, una frangia oscura, la cui intensità luminosa viene misurata da un fotodiodo. Se un'onda gravitazionale dovesse deformare la geometria del sistema, la sfasatura dei due raggi risulterebbe alterata e il fotodiodo percepirebbe un'infinitesima variazione di luce. Perché questo accada tutti gli apparati devono essere calibrati in modo da evidenziare spostamenti un miliardo di volte più piccoli di un atomo, eliminando rumori e vibrazioni di natura terrestre. A questo scopo gli specchi, di altissima precisione, sono sospesi a dei dispositivi, chiamati super-attenuatori, che hanno la funzione di isolarli meccanicamente dal contesto terrestre, in modo da eliminare gli effetti delle sorgenti di disturbo. Grazie a tutti questi accorgimenti, Virgo risulterà sensibile a un vasto spettro di onde gravitazionali, da circa 10 a 6000 Hertz di frequenza, e potrà captare segnali le cui sorgenti si trovano sia all'interno della Via Lattea, che in galassie esterne, fino alla distanza dell'ammasso della Vergine (da cui il nome dato all'apparato) che si trova a oltre 3 milioni di anni luce. L'esperimento coinvolge, in Italia, gruppi di Pisa, Napoli, Frascati, Roma, Perugia e Firenze; in Francia di Orsay, Annecy, Nizza, Parigi e Lione. Alla sua direzione si sono alternati, finora, il fisico francese Alain Brillet e quello italiano Adalberto Giazotto (attuale direttore).Virgo non sarà sola a cimentarsi con la ricerca delle onde gravitazionali e con le difficoltà delle misure estreme. Appena ultimata, nel 2001, sarà interconnessa con analoghi strumenti in corso di realizzazione negli Stati Uniti e in Germania, in modo che, in caso di segnale positivo, si possano ottenere conferme incrociate.In prospettiva si spera di disporre, attraverso le onde gravitazionali, di un nuovo tipo di radiazione che, per la scarsa interazione con la materia, sia capace di portare informazioni su regioni dello spazio remote e occultate da gas, polveri e ammassi di stelle, come il centro delle galassie; addirittura di testimoniare le prime fasi di esistenza dell'Universo, subito dopo il big bang, quando ancora non c'era radiazione elettromagnetica libera e la gravità dominava lo spazio. |
|