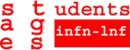Questa è l'intervista al professor Ralf Lehnert, il quale tramite e-mail ci ha parlato di sè e del suo lavoro.
Mi chiamo Ralf Lehnert. Sono originario di Dresda in Germania. Ho studiato fisica in Germania e più tardi negli Stati Uniti. Dopo essermi laureato in fisica teorica, ho lavorato come associato post-dottorato in Portogallo, negli Stati Uniti e in Germania. Al momento sono ricercatore all’Universidad Nacional Autonoma de México di Città del Messico. Mi piacerebbe diventare un professore di fisica all’università perché voglio far convivere le mie due passioni: la ricerca e l’insegnamento della fisica.
D: Come e perchè ha deciso di studiare fisica e qual è il ricordo più bello della sua vita da studente?
Mio padre è un ingegnere, e quando ero un bambino, nutrì la mia curiosità su come funzionano le cose. Ad esempio, costruiva alcuni giocattoli con me, dimostrava semplici e divertenti esperimenti, e mi fece appassionare agli enigmi matematici. Nella scuola superiore, fisica e matematica divennero le mie materie preferite, e partecipai a competizioni in queste materie a livello regionale e nazionale. Rimasi affascinato dal fatto che una pletora di fenomeni naturali possa essere spiegata con solo una manciata di principi generali usando il preciso linguaggio della matematica. Il fascino di questa semplicità e chiarezza, come pure il mio desiderio di comprendere la natura e la mia passione per il ragionamento razionale, mi hanno spinto alla decisione di studiare fisica.
Ho innumerevoli ricordi indimenticabili del mio periodo da studente, ed è difficile isolare un’esperienza particolare. Sfruttai la mia libertà e indipendenza in quanto studente: potevo dedicare la maggior parte del mio tempo alla fisica, vivevo e studiavo in un altro paese, mi feci molti nuovi amici, andavo spesso alle feste e, nella pausa di semestre, viaggiai agli angoli estremi del mondo… Un eccitante ricordo in fisica riguarda un compito a casa sulla meccanica classica, spinta d’Archimede e termodinamica.
Le mie ragioni teoriche non furono sufficienti a convincere i miei compagni di studio dell’esistenza di un certo fenomeno relativo a questo problema. Comunque, l’equipaggiamento necessario era abbastanza semplice da permettere un test immediato in laboratorio e funzionò esattamente come avevo predetto.
Ciò che rende questo ricordo così speciale per me è il fatto che non c’era nessun effetto, né esperimento già documentato; per la prima volta, avevo effettuato una predizione teorica e avevo condotto l’esperimento corrispondente da solo, ed entrambi erano coerenti!
D: Quali difficoltà ha dovuto affrontare nella sua carriera e qual è stato l'episodio più entusiasmante?
Per la maggior parte non ho incontrato grandi difficoltà nei miei studi di fisica. Ciò che segue ha richiesto degli adattamenti da parte mia che forse può valere la pena raccontare. Il ritmo dell’istruzione all’università è molto più veloce rispetto alla scuola superiore. Mentre le lezioni spesso trasmettono la sensazione che l’argomento trattato sia chiaro, ho trovato altrettanto importante lavorare praticamente sui problemi.
Ho avuto una serie di esperienze eccitanti nella mia carriera. Un esempio potrebbe essere la mia prima pubblicazione scientifica in un giornale di fisica. Avevo lavorato sull’argomento per alcuni anni; vari problemi tecnici e concettuali dovevano essere risolti; e i risultati erano in certi casi sorprendenti e alcuni corrispondevano molto bene con le nostre aspettative. Quando i risultati vennero finalmente stampati, esaminati e pubblicati, tutto ciò mi diede un senso di soddisfazione e realizzazione. Comunque, sto ancora sperimentando momenti eccitanti: ad esempio, quando arrivo alla soluzione di un difficile problema di ricerca che nessun altro ha risolto prima. Proprio per il piacere che traggo dalla ricerca fisica sono diventato un fisico. Penso che continuerò a divertirmi con la fisica, e i momenti più eccitanti della mia carriera sono forse ancora davanti a me…
D: Su cosa sta lavorando attualmente?
La mia area di esperienza è la teoria della fisica delle particelle elementari. Sono particolarmente interessato alla teoria della relatività di Einstein. Le moderne idee teoriche suggeriscono che ci possono essere minime deviazioni dalla teoria della relatività.
La mia ricerca riguarda quanto segue: considero le equazioni stabilite come convenzionali per le particelle elementari, che sono in armonia con la teoria della relatività. Modifico quindi le equazioni affinché esse descrivano situazioni nelle quali la relatività non è completamente (ma per la maggior parte) valida.
Devo assicurarmi che queste modifiche soddisfino alcuni importanti criteri, come la consistenza interna, consistenza con osservazioni e consistenza con altri principi fondamentali di fisica. Con queste equazioni modificate posso fare quindi predizioni sull’esito di ciascun esperimento se la teoria della relatività non fosse del tutto corretta. Tali risultati permettono ai miei colleghi fisici sperimentali di identificare e ideare i migliori test possibili per la teoria della relatività.
Nessuna convincente evidenza sperimentale per le deviazioni della teoria della relatività di Einstein è stata ancora trovata, ma gli sperimentali continuano ad avvicinarcisi…
D: Quale crede possa essere la prossima scoperta in fisica?
Ogni giorno, nuovi scritti di fisica, che presentano risultati sperimentali o idee teoriche, sono disponibili. Ognuno di questi spesso si può qualificare come piccola scoperta. Credo che la prossima scoperta-chiave con l’impatto maggiore sarà molto probabilmente un risultato sperimentale. Per esempio, ci sono parecchi esperimenti che hanno la potenzialità di scoprire nuove particelle (LHC e forse il Tevatron), le onde gravitazionali (LIGO ecc.), o la materia oscura (CDMS, CRESST e DAMA\LIBRA).
Nel mio campo di esperienza, molti test ad altissima precisione della relatività, che potrebbero rilevare una nuova struttura dello spazio-tempo su scale estremamente piccole, sono in fase di svolgimento e attendo con impazienza i loro risultati. Al momento, ci sono anche tentativi di misurare le proprietà sconosciute dei neutrini. Comunque, penso ci siano anche importanti problemi teorici che devono essere risolti, come la superconduttività ad alte temperature. In ogni caso, credo che gli anni prossimi saranno eccitanti per i fisici grazie ai passi in avanti della comprensione della natura a livello fondamentale.
D: Quale ritiene sia stata la scoperta più grande in fisica e qual è il suo scienziato preferito?
È difficile dare risposte precise a queste due domande. Certamente, molte affascinanti scoperte scientifiche sono state compiute nel corso della storia ed ammiro un certo numero di scienziati. Durante i miei studi universitari ero particolarmente affascinato dalla teoria dei quanti: aldilà dell'utilizzazione di nuovi strumenti matematici, questa teoria richiede un nuovo modo di pensare che è fortemente in contrasto con quello della fisica classica.
Uno dei miei scienziati preferiti è Galileo Galilei. Oltre ad aver posto le basi della meccanica classica, ha anche contribuito in molti altri campi della scienza. Ma per me Galileo è un modello da seguire in questo senso: è stato uno dei primi a sottolineare il collegamento della scienza all’osservazione e alla sperimentazione, un concetto così importante che è sopravvissuto per mezzo millennio! Per tutta la sua vita è rimasto fermamente convinto dei suoi risultati di ricerca, anche quando fu messo davanti all’Inquisizione Romana.
D: Quanto è importante la collaborazione nella ricerca scientifica anche tra nazioni diverse?
Per diversi rami della ricerca, come l’esplorazione spaziale o la fisica sperimentale delle alte energie, le collaborazioni internazionali sono uno strumento cruciale per assicurarsi fondi.
In qualche caso, collaborazioni scientifiche fra Stati possono anche simboleggiare l’integrazione politica.
Ma oltre gli aspetti politici e finanziari, la ragione primaria per la cooperazione è chiaramente di natura scientifica: unire l’esperienza di differenti ricercatori e istituzioni. Personalmente, mi piace lavorare insieme ad altri ricercatori: il problema può essere esaminato da diverse angolazioni, frutto di differenti culture scientifiche; mi aiuta a non arenarmi su una singola difficoltà; imparo più velocemente quando confronto i miei risultati con quelli dei miei colleghi; spesso nascono idee per ulteriori ricerche.
In breve, direi che per me i risultati di collaborazioni spesso eccedono la somma dei contributi di ogni singolo ricercatore.
D: Come si definisce uno scienziato e in che modo talento, intuizione e studio influiscono sulla sua professione?
Uno scienziato è di solito un esperto riconosciuto in un’area della conoscenza (fisica, matematica, fisiologia…) ed è anche interessato in un ulteriore studio sistematico di questa area usando il metodo scientifico. Penso che dei buoni scienziati abbiano menti critiche ed analitiche. Il talento è certamente un altro attributo importante: identificare i tuoi talenti aiuta nello scegliere una carriera. Ma il talento da solo non fa il buono scienziato. È anche necessario acquisire una conoscenza in profondità del campo di studi scelto, che implica un duro lavoro per svariati anni.
L’intuizione è sicuramente molto utile per gli scienziati. Comunque, penso che caratteristiche personali come curiosità, creatività, astrazione, diligenza, obiettività e persistenza siano ugualmente importanti. Ma la qualità di base che io considero fondamentale per gli scienziati, è il desiderio e la spinta interiore per comprendere (alcuni aspetti) della natura. Senza questo stimolo, è difficile essere uno scienziato.
D: Quali sono i suoi hobbies e passioni e quale libro ci consiglia di leggere?
Oltre la ricerca nel campo della fisica, mi piacciono tutti i tipi di attività all’aperto, come fare escursioni, campeggiare e sciare. Quando ho poco tempo e ho bisogno di distogliere la mente dal lavoro, vado a nuotare, a correre o guardare un bel film.
Ora che sono in Messico, voglio visitare molti dei siti archeologici pre-colombiani sparsi attraverso tutta l’America centrale e meridionale e voglio studiare le civiltà Azteche, Maya, Inca…
Uno scorrevole romanzo thriller che potreste trovare piacevole da leggere è “Angeli&Demoni” di Dan Brown. L’ho trovato abbastanza interessante, specialmente la parte del libro ambientata al CERN (il più grande laboratorio di fisica nel mondo) e la trama addirittura abbraccia questioni di fisica. Comunque, in questo senso, non tutti i ragionamenti presentati nel libro sono corretti. Riuscite a trovare le inesattezze?
D: Come vede il futuro della ricerca in questo periodo di crisi economica mondiale?
La recessione economica globale ha certamente un effetto sulla scienza: un esempio è il blocco temporaneo delle assunzioni a molte università. Per il 2009, un diminuzione delle spese complessive negli Stati Uniti di R&D –la prima caduta in dieci anni- è stato previsto. Una ragione per questa involuzione è il fatto che parte dei fondi alla ricerca vengono dall’industria, donazioni private, fondazioni e dotazioni e tutte queste risorse saranno probabilemente influenzate dall’abbassamento dei tassi di interesse. In altre parole, credo che nel futuro ci saranno sfide per la ricerca. Comunque, R&D è una pietra angolare di una forte e florida economia.
Fondi incrementati per la ricerca sembrerebbero quindi una misura necessaria per superare la crisi. Infatti, negli Stati Uniti, un pacchetto stimolo, che includa addizionali risorse per quasi nove milioni di dollari, è stato recentemente approvato. Così in questo senso, la crisi potrebbe potenzialmente determinare esiti creativi.